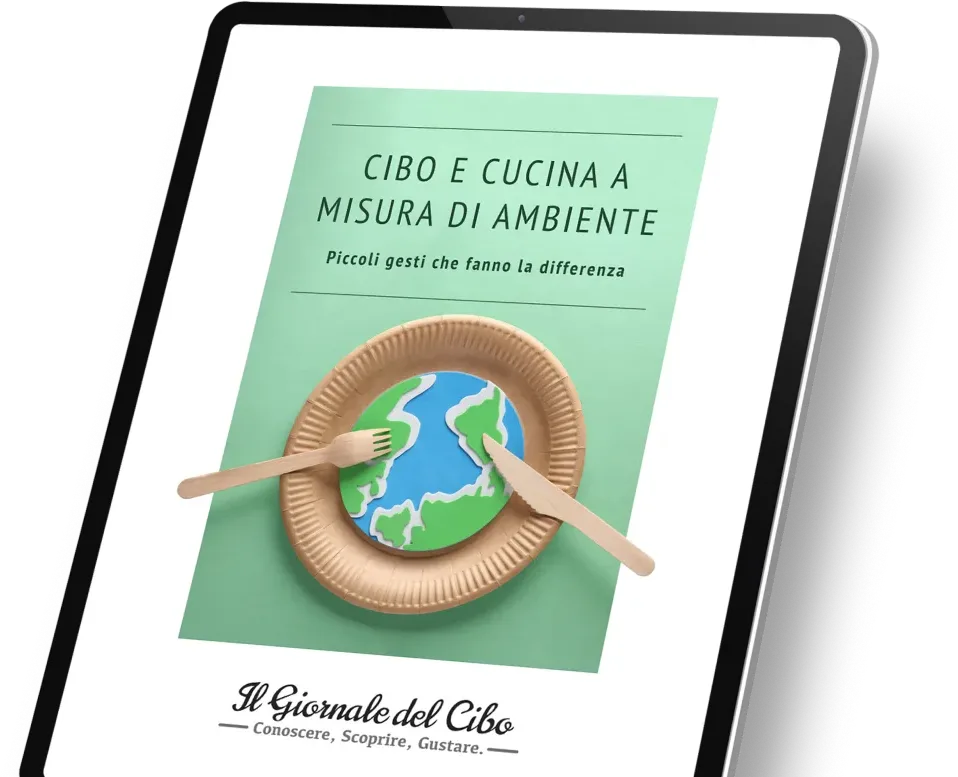In Italia non è ancora tempo per la sugar tax, dopo l’ennesimo rinvio stabilito dalla Commissione Finanze del Senato nello scorso maggio. L’iter di questa legge, infatti, è stato più che mai travagliato e ostacolato, dopo l’iniziale approvazione avvenuta nel 2020. Ma cosa frena ancora oggi questo provvedimento nel nostro Paese e quali potrebbero essere le conseguenze della sua introduzione? Tra pareri favorevoli e contrari, facciamo il punto dopo la recente decisione del governo italiano.
Sugar tax in Italia: un altro rinvio fissato a luglio 2025

Sarebbe dovuta entrare in vigore il primo luglio di quest’anno, e invece per la sugar tax è arrivato un rinvio che rimanda al 2025, sancito dalla Commissione Finanze del Senato, con una modifica introdotta nel decreto Superbonus. L’accordo in questa direzione tra i partiti della maggioranza è stato annunciato dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, e nelle ore precedenti il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva esplicitato la volontà – e lo sforzo – di trovare una copertura finanziaria per il rinvio. In seguito, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri ha lodato la decisione come “una vittoria” per il proprio partito, da sempre contrario alla tassa.
La vicenda della sugar tax in Italia ha avuto sviluppi analoghi a quelli della plastic tax, per la quale però il Governo si è preso un anno in più, rinviandola al luglio 2026.
Da Palazzo Chigi si è poi ricordato che sugar e plastic tax sono state introdotte dal Governo Conte 2 con la legge di Bilancio 2020 e finora sempre rinviate, anche durante la guida di Mario Draghi: la sugar tax doveva inizialmente entrare in vigore nel gennaio 2021. Il Governo, inoltre, ha voluto sottolineare l’intenzione di accogliere le istanze delle imprese del settore.
La sugar tax, tra obiettivi e dibattito politico
Con questa definizione, ormai largamente conosciuta, si intende un’imposta sulle bevande zuccherate che ha l’obiettivo di contrastare l’obesità e tutte le conseguenze negative sulla salute legate al consumo eccessivo di zuccheri. La misura, pensata inizialmente per diminuire i consumi di bibite, come vedremo ha conosciuto diverse applicazioni sulla base della strategia perseguita.
In Italia, ormai da alcuni anni, l’introduzione di questa tassa è quanto mai controversa, e nemmeno l’idea di indirizzare i consumatori verso scelte più salutari con un provvedimento simile mette d’accordo tutti. Anche la proposta di ridurre l’aliquota – da 10 a 5 euro per ettolitro per i prodotti finiti e da 0,25 a 0,13 euro per chilo per i prodotti diluiti – ha attirato le critiche rispetto alla reale efficacia della misura e sulle sue conseguenze economiche e sull’occupazione. Negli anni scorsi, sul provvedimento ha pesato la pandemia Covid-19, influenzando le decisioni politiche ed economiche e portando il governo in carica a rimandare la tassa, per evitare ulteriori pressioni su un’economia già colpita dalla crisi sanitaria.
Il no delle associazioni di categoria

Come è facile intuire, da parte dei produttori di bevande dolcificate è massima l’opposizione a questa misura. Prima del rinvio deciso dal governo Meloni, Assobibe (Associazione dei produttori di bevande analcoliche) ha stimato una contrazione delle vendite del 16%, con conseguenti tagli agli investimenti e di 5.000 posti di lavoro in Italia, dove peraltro si registrano i consumi di bibite più bassi d’Europa. A questo, andrebbe ad aggiungersi un aumento dei prezzi al consumatore finale, in quanto le aziende scaricherebbero, almeno in parte, il costo della tassa sui prodotti. Il provvedimento, oltre ad aumentare la fiscalità del 28% per le aziende, determinerebbe un calo degli acquisti di materia prima di più di 400 milioni di euro, una contrazione degli investimenti per oltre 46 milioni di euro e un aumento del carico burocratico.
Anche Coldiretti ha espresso la propria contrarietà alla sugar tax, definita una “misura distorsiva che penalizza imprese e famiglie, danneggiando la filiera agroalimentare made in Italy. Siamo stati i primi a chiedere pubblicamente un intervento del Governo per rivedere una tassa che rischia di danneggiare le imprese agroalimentari già colpite dall’aumento dei costi di produzione causato dalle guerre e dalle tensioni internazionali”, ha dichiarato il presidente Ettore Prandini.
La sugar tax nel mondo
Anche se in Italia si ragioni ancora in termini di rinvii, la sugar tax da alcuni anni è realtà in molte nazioni del mondo, come risposta concreta all’aumento delle malattie legate all’obesità, al diabete di tipo 2 e ad altre patologie correlate al consumo eccessivo di zuccheri.
In parallelo rispetto alle tasse, le strategie finora adottate, oltre a scoraggiare l’acquisto da parte dei consumatori, in gran parte si sono concentrate su queste basi:
- incentivare le industrie a riformulare i prodotti, diminuendo la quantità di zucchero;
- vietare la pubblicità di cibi ad elevato contenuto di zuccheri, sale e grassi destinati ai bambini;
- adottare etichette a semaforo per aumentare la consapevolezza dei consumatori sulla salubrità di quello che mangiano e bevono;
- promuovere corsi di educazione alimentare nelle scuole.

Stockah/shutterstock
Ecco alcune casistiche diverse tra loro, dal punto di vista geografico, sociale e politico.
- In Francia la legge è stata introdotta nel 2012 su tutte le bevande con aggiunta di zucchero o edulcoranti, quindi anche sulle bibite “light”. L’imposta inizialmente prevedeva un prelievo fisso di 7,53 €/ettolitro e ha portato a un incremento generalizzato sui prezzi delle bevande, in particolare su quelle a base di frutta. Dal 2018 l’aliquota è stata alzata: la tassa per una bevanda con il 4% di zuccheri è di 0,045 €/l, per una con il 10% si arriva a 0,135 €/litro, mentre per una con il 15% il costo aggiuntivo è di 0,235 €/litro.
- Nel Regno Unito la Soft drinks industry levy (SDIL) risale al 2018 e riguarda le bevande analcoliche o poco alcoliche che superano una certa soglia di zuccheri aggiunti. I succhi di frutta naturali, le bevande a base di latte sono esenti, come lo sono quelle a zero zucchero, aspetto che la differenzia dalla sugar tax francese. La tassa vale l’equivalente di 0,20 €/litro per bibite con un contenuto da 5 a 8 grammi di zuccheri per 100 ml, mentre se il contenuto supera gli 8 grammi si sale a 0,27 €/litro. Negli anni successivi all’introduzione, più di metà dei produttori ha diminuito il contenuto di zucchero.
- Negli Stati Uniti non esiste una sugar tax federale, ma alcune città hanno adottato provvedimenti specifici e il tema è stato discusso anche al Congresso. A Berkeley (California), ad esempio, la tassa esiste dal 2015 e vale 1 centesimo di dollaro per ogni 30 ml di bibita: una lattina da 330 ml, quindi, viene a costare 10 centesimi in più.
- In Messico, dove il consumo di bibite era particolarmente elevato, la sugar tax esiste dal 2014 e vale 0,04 €/litro per le bevande zuccherate, circa il 10% del prezzo. Secondo una rilevazione nazionale, nei due anni successivi all’imposta si è registrata una riduzione media del 7,6% dell’acquisto di bevande zuccherate tassate e un aumento del 2,1% degli acquisti di quelle non tassate, soprattutto di acqua, oltre a un introito fiscale superiore a 2,6 miliardi di dollari. Rispetto alla tassa inglese, quella del Messico è forfettaria ed è concepita soprattutto per inibire il consumo, mentre nel Regno Unito si è puntato di più a stimolare le riformulazioni da parte dei produttori.
Per quanto controversa, la sugar tax ha dimostrato di essere una misura potenzialmente efficace per ridurre il consumo di zuccheri e per migliorare la salute pubblica. La sua implementazione e i suoi effetti, come abbiamo visto, variano a seconda del contesto nazionale, sociale ed economico, come delle strategie collaterali adottate e delle risposte dei consumatori e delle industrie. Il caso italiano, inoltre, è un esempio di come le politiche fiscali possano essere influenzate da vari fattori, tra cui pressioni industriali, crisi economiche e dibattiti pubblici. Sebbene la sua introduzione sia stata posticipata al luglio 2025, resta un tema importante nel contesto delle politiche di salute pubblica e della lotta contro il consumo eccessivo di zuccheri.
Immagine in evidenza di: BearFotos/shutterstock