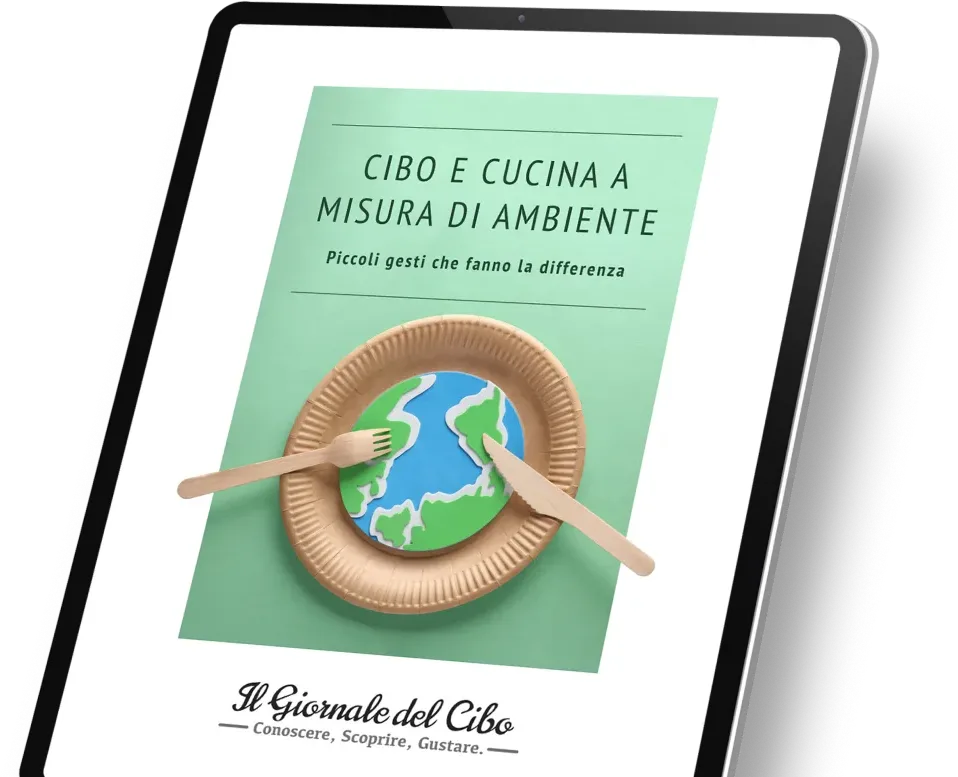Per gli italiani, la cucina e i prodotti tipici sono tra i pilastri dell’identità nazionale, un vanto che ci rende orgogliosi nel mondo, e in genere ci fa guardare dall’alto al basso le altre culture gastronomiche. E se questa ricchezza, della quale non dubitiamo rispetto alle antiche origini, fosse invece un’invenzione recente? Seguendo le ricostruzioni di Denominazione di origine inventata, le cose starebbero proprio così, e molte delle eccellenze che riteniamo radicate in un passato lontano sarebbero state concepite solo a partire dagli anni Settanta.
Per saperne di più, per questo approfondimento speciale abbiamo intervistato il professor Alberto Grandi, docente di Storia dell’alimentazione all’Università di Parma e autore di questo saggio che fa discutere, smontando alcune delle nostre certezze più granitiche in fatto di cibo.
Denominazione di origine inventata: come stanno le cose?

Il Parmigiano Reggiano più fedele alla tradizione e all’esperienza secolare dei monaci emiliani oggi si fa negli Usa, più precisamente nel Wisconsin: è il famigerato Parmesan, nemico giurato delle nostre produzioni. I dolci pomodori di Pachino, così legati alla Sicilia, sono invece ibridi di laboratorio creati da una multinazionale israeliana. L’olio extravergine d’oliva anticamente non era usato dagli italiani, nemmeno al Sud, dove lo strutto e altri grassi di pregio inferiore erano ben più popolari. Questi, e molti altri, sono i miti sgretolati da Denominazione di origine inventata, un saggio che di primi acchito farà male agli innamorati della nostra tradizione gastronomica, o perlomeno di quella che abbiamo sempre ritenuto autentica.
Secondo le tesi espresse da Alberto Grandi nel suo libro, infatti, molti dei piatti, dei prodotti e la stessa dieta mediterranea – pur essendo eccellenti – sono accompagnati e decantati da leggende di un antico passato di sapienze, costruite fra gli anni Settanta e Novanta. In quel periodo, per rispondere alla crisi industriale, l’impresa e i produttori italiani si sarebbero alleati, inventando ad arte una tradizione millenaria dei nostri cibi, in seguito sostenuta da una narrazione dimostratasi molto efficace.
Gran parte di queste cosiddette tradizioni, pertanto, sono sostanzialmente inventate, afferma Grandi, aggiungendo che alcune produzioni industriali possono vantare una storia più antica di molte altre comunemente considerate artigianali. Superata l’iniziale irritazione, come detto, questo saggio ha il merito di instillare negli appassionati del cibo italiano una riflessione razionale, che peraltro non deve mettere in discussione l’effettiva qualità dei nostri prodotti.
La svolta degli anni Settanta
In linea con le tesi del saggio in questione, viene da chiedersi perché proprio negli anni Settanta si sia verificato questo passaggio così significativo per la costruzione di identità dei cibi italiani. In quel decennio, prosegue il professore, finisce il boom economico iniziato negli anni Cinquanta, e l’Italia comincia a interrogarsi sul suo futuro economico. Il recupero di un passato bucolico e mitizzato, a quel punto, diventa un ancoraggio rispetto alla perdita di identità determinata dall’industrializzazione, che prima era stata messa in secondo piano rispetto al fortissimo incremento del tenore di vita della popolazione.
Gli anni Settanta si sono caratterizzati per una seria di eventi epocali. Sul finire del decennio precedente, l’autunno caldo aveva palesato che nelle dinamiche lavorative delle fabbriche c’erano problemi forti e dissidi, dove l’industria creava fratture sociali più o meno gravi, in base ai diversi contesti locali.
Nel 1971, inoltre, esplode la crisi del dollaro, che interrompe una fase di stabilità dei prezzi consolidata da vent’anni, situazione aggravata nel ‘73 con la crisi petrolifera, che mette in discussione tutto il modello industriale. Il disastro chimico di Seveso del 1976 amplifica questi dubbi, spingendo a interrogarsi sulla sostenibilità ambientale di quel sistema di sviluppo. Tutte quelle domande, fino ad allora accantonate, lasciano aperte una serie di questioni di grande rilievo economico e sociale.
Mentre gli altri Paesi industrializzati iniziano una fase di trasformazione e di ristrutturazione del sistema produttivo, in Italia questo avviene solo in parte, e si risponde col modello delle piccole imprese, dei distretti industriali e delle produzioni tipiche, che in realtà tali non sono. Si tratta comunque di un modo per costruire un legame coi territori, sulla quale poggiare un’intera economia. La riforma delle Regioni del 1970 e altre iniziative, inoltre, supportavano già una politica territoriale che ha portato alla realtà oggi ormai consolidata.
Dalla sussistenza alla qualità
Il professor Grandi sottolinea che è sbagliato ritenere a priori negativo questo passaggio e la creazione della tipicità, perché “in quarant’anni siamo riusciti a costruire una grande identità gastronomica, che fino a quel momento non avevamo. Prima l’Italia produceva ben poca qualità, mentre adesso siamo tra le grandi gastronomie internazionali. Il mio è un atto d’amore nei confronti della cucina italiana: in generale, il nostro è un caso di grande successo, non solo del marketing ma anche nella sostanza, perché effettivamente i prodotti che oggi consumiamo ed esportiamo si distinguono per una qualità mediamente alta”.
Il professore prosegue precisando che l’Italia, soprattutto entro i confini, passa per essere un Paese dove si è sempre mangiato bene, ma questo non è assolutamente vero, perché i nostri avi hanno sempre mangiato poco e male. “A Nord del Po, i contadini si nutrivano quasi esclusivamente di polenta, e alle soglie della Seconda guerra mondiale uno su tre aveva la pellagra. Fino al 1945, il 60-70% delle spese alimentari degli italiani del Settentrione erano destinate all’acquisto di farina di mais, mentre nel 1950 questo dato passa al 6%. Basta parlare coi nostri nonni per avere riscontro di queste memorie”, aggiunge Grandi.
Perché proprio in Italia?

Tenendo presente questa trasformazione, è lecito chiedersi per quali motivi tutto ciò sia successo proprio nel nostro Paese. Per il professore, determinanti sono state le modalità di sviluppo precedente, durante il boom economico, quando il passaggio da società rurale a industriale è stato talmente repentino da risultare abbastanza superficiale. Quindi, secondo Grandi, nel primo momento di difficoltà, ovvero negli anni Settanta, dove in tutto l’Occidente il modello viene messo in discussione, in Italia si registra una sorta di reazione spontanea.
Fino ad allora, gli italiani avevano gradito tutto ciò che era moderno, e negli anni Cinquanta e Sessanta, infatti, la cosa buona era industriale: quello che era moderno, confezionato o surgelato era automaticamente ritenuto migliore rispetto alle produzioni tradizionali. A partire da quella decade, però, la fiducia totale nella modernità e in quella forma di sviluppo viene meno.
Cosa è accaduto negli altri Paesi?
Seguendo il ragionamento espresso in Denominazione di origine inventata, resta da domandarsi cosa sia successo di diverso nelle altre nazioni dove la cultura gastronomica è particolarmente importante, la Francia su tutte. Per Grandi, “posto che il sistema delle denominazioni è stato inventato Oltralpe, con il modello Champagne, anche in Francia si è verificato questo fenomeno. Tuttavia, meno che in Italia, perché la loro cucina ha una storia più radicata, la nazione unitaria è più antica e l’evoluzione gastronomica del Paese ha avuto inizio prima di quella italiana. Non a caso, in Francia la dignità della nostra gastronomia ha avuto un riconoscimento tardivo rispetto agli altri Paesi, e il primo ristorante a ottenere le celebri tre stelle della Guida Michelin è stato quello di Gualtiero Marchesi, non prima del 1986”. Il processo di industrializzazione francese, inoltre, è più profondo e antico, e questa somma di fattori ha generato un fenomeno progressivo e meno brusco se confrontato al caso italiano.
Il cibo tra marketing e mito
Nel successo del marketing, che ha fatto leva su uno storytelling basato sulla creazione di una tradizione ancestrale e mitizzata, fondamentali sono state alcune dinamiche che determinano le preferenze d’acquisto. Il professore cita un saggio dello psicologo statunitense Paul Bloom, La scienza del piacere, che afferma l’influenza decisiva di ciò che si conosce di un cibo – ad esempio, chi e come lo prepara, chi lo consuma oltre a noi – sull’apprezzamento dei consumatori, al di là delle mere percezioni sensoriali.
Il marketing sfrutta questi aspetti, e la storia di un prodotto diventa assai rilevante, perché può rassicurare, oltre a creare un immaginario e uno status legati a un cibo. Del resto, sono molti gli esempi che le pubblicità televisive ci offrono in questo senso, con narrazioni spesso palesemente o ironicamente inverosimili rispetto alla realtà.

Ma non tutto è creato ad arte
Pensare che gran parte della nostra identità gastronomica sia inventata non è confortante, ma perlomeno ci sono realtà italiane la cui origine è davvero antica. Alberto Grandi afferma che “ovviamente non si può inventare tutto, ed è vero che ci sono cucine, piatti, prodotti e preparazioni con una storia più lunga, in alcuni casi anche molto antica”.
Il professore cita la polenta, ma anche prodotti che pur essendosi evoluti per diversi aspetti, a partire dalle materie prime, hanno comunque un lungo passato. “Fra questi c’è la pasta sfoglia ripiena, che esiste dal Cinquecento, come altre preparazioni legate alla tradizione delle corti rinascimentali, che in seguito in Italia quasi spariscono per poi ritornare grazie ai francesi. Non a caso, fino all’Ottocento, la cucina dei nobili italiani è prettamente transalpina, tanto che in casa Savoia, fino alla morte di Umberto I, i menù erano in lingua francese”. Parlando del dibattito fra tagliatelle e spaghetti alla bolognese, insieme a Giorgio Palmeri dell’Accademia della Cucina, abbiamo ripercorso la storia della pasta sfoglia ripiena.
La pizza, prosegue Grandi, ha una tradizione secolare, pur essendo da attribuire all’area mediterranea e non solo a Napoli. Tuttavia, è vero che la si mangiava con le mani e per strada, mentre la prima pizzeria probabilmente apre a New York, e non all’ombra del Vesuvio.
Anche in questi casi di ‘autenticità’, tuttavia, si è manifestata la tendenza a costruire storie e a ricamare le vicende del passato. Mantova e Ferrara, ad esempio, si contendono i natali dei tortelli di zucca, talvolta citando – rispettivamente a proprio favore – il ruolo di un personaggio storico come Isabella d’Este Gonzaga. Peccato, però, che all’epoca della nobildonna ferrarese la zucca non fosse ancora stata introdotta nella pianura padana… Quindi, non tutto è stato inventato, ma tanto lo è, e in queste operazioni spesso ci siamo fatti prendere la mano”.
Il caso del Parmigiano Reggiano

Nella serie di ricostruzioni in bilico fra storia e fantasia presentate in Denominazione di origine inventata, quello del Parmigiano Reggiano è certamente un caso emblematico.”Si tratta di un prodotto dalla storia travagliata, con ‘buchi’ di svariati decenni. Nel tempo è stato sottoposto a evoluzioni significative, tanto che le forme consumate oggi sono completamente diverse da quelle originariamente prodotte dai monaci emiliani nel Medioevo, ma anche da quelle realizzate fino agli anni Cinquanta. È vero che ne parla Boccaccio, ma quando i francesi nel 1797 arrivano in Italia e lo cercano a Parma, per carpirne la ricetta, non lo trovano… Pertanto, c’è un vuoto storico di almeno 150 anni, riconosciuto anche dagli studiosi locali”.
Anche al netto di queste vicende, secondo Grandi, oggi il Parmigiano più fedele alla versione del passato si produce nel Wisconsin, dove nei primi del Novecento molti casari emiliani sono emigrati, creando il famigerato Parmesan, l’alimento più vituperato e osteggiato dai patrioti del Made in Italy. Gli italoamericani del Wisconsin – non a caso detto the dairy state (Stato del formaggio e dei latticini) – continuano a produrlo come si faceva in Emilia negli anni precedenti alla Prima guerra mondiale, ovvero quando gli avi di questi casari a stelle e strisce sono emigrati oltreoceano. “Se si vanno a vedere i cognomi dei fondatori dei caseifici che producono il Parmesan da più tempo, cioè almeno dagli anni Venti e Trenta, si noterà la loro origine padana: Magnani o Rossi, per citarne due” precisa Grandi.
Con tutta probabilità, quindi, i fondatori conoscevano bene il mestiere prima di emigrare, e hanno esportato le loro competenze, continuando a fare il formaggio come avevano imparato nella terra d’origine. Negli Usa, l’evoluzione che in patria ha proseguito a marciare si è bloccata, forse perché il prodotto ha subito incontrato il gusto dei consumatori e non ha avuto necessità di cambiare. Per chiarire questo tipo di cristallizzazione temporale, possiamo ricordare che un fenomeno simile accade per le lingue: nel Québec, ad esempio, tuttora si parla una forma di francese diversa da quella contemporanea di Parigi e molto simile a quella del Settecento, quando i colonizzatori transalpini governavano la regione canadese.

Il proliferare delle denominazioni è utile o controproducente?
Nell’argomentazione di Denominazione di origine inventata, la grande diffusione delle denominazioni – Doc, Docg, Dop, Igp e Igt – è criticata, nonché ritenuta in grado di causare danni alle stesse produzioni. Secondo il professore, “le situazioni sono molto diverse ed è difficile dare una risposta univoca. A mio giudizio, la denominazione in sé non garantisce niente ed è irrilevante ai fini del successo sul mercato. La differenza è determinata dalla qualità dei prodotti e dalle capacità di promuoverli”.
A Modica, ad esempio, grazie al cioccolato – la cui storia è inventata – il paese è cambiato, e sono sorti un consorzio, un museo ed eventi di rilievo internazionale, aggiunge Grandi. Questo è un caso di grande successo, dove si è costituito un intero sistema economico. Nel caso della focaccia di Recco, invece, la denominazione rischia di far sparire il prodotto, con una situazione paradossale. Per il professore, comunque, si è esagerato: in Italia c’è una corsa alla denominazione, con una deriva potenzialmente pericolosa per il nostro agroalimentare, anche se nel mercato c’è spazio per tutti. Questo fenomeno, peraltro, potrebbe favorire la gentrificazione, come abbiamo visto nel nostro approfondimento.
Probabilmente, secondo Grandi, bisognerà trovare un punto d’equilibrio, distinguendo fra prodotti per il mercato interno e altri per quello internazionale, o fra versioni commerciali e produzioni d’eccellenza, dedicate a una nicchia di clienti con disponibilità superiori. In questo senso, “il modello di riferimento è quello dell’aceto balsamico, dove esiste la Dop tradizionale, altamente esclusiva, e la Igp, ben più accessibile e dai volumi enormemente superiori. I due prodotti non hanno nulla in comune, ma in qualche modo si supportano a vicenda. Da un lato, il prodotto industriale si giova del mito di quello tradizionale, che invece è trainato dalla diffusione e dai grandi numeri di quello commerciale”.
Cibo e globalizzazione: qual è lo scenario futuro?

Alla luce di queste considerazioni, restano i dubbi sul futuro e sui cambiamenti che potrebbero interessare il mercato. Per Alberto Grandi, l’aspetto più rischioso è che la quota dei consumatori sensibili a questo tipo di storytelling si sta restringendo. Le nuove generazioni spesso considerano poco le tradizioni, magari preferendo cucine esotiche o internazionali in voga, e a questo proposito il successo mondiale del sushi è emblematico.
“Ho l’impressione che ci sarà sempre una quota di consumatori avveduti, interessati e curiosi rispetto alle tradizioni – vere o presunte non conta, d’altra parte quelle recenti fanno presto a radicarsi e a essere riconosciute – ma spingere troppo su questa leva potrebbe avere un contraccolpo. Il mercato si sta evolvendo e sta inglobando altri valori” sostiene Grandi.
Inoltre, secondo il professore, c’è un altro aspetto da considerare: gli italiani tendono a sopravvalutare la considerazione della loro cucina nel mondo, che pure ha una grande reputazione. Come riporta Grandi, “lo scorso anno il New York Times ha svolto un’indagine fra i suoi lettori, per stabilire i 50 piatti migliori al mondo, e solo due sono risultati italiani: la pizza e le fettuccine Alfredo, che peraltro non sono esattamente italiane. In sostanza, ci raccontiamo un primato che, per diverse ragioni – produttività, comunicazione, innovazione e non solo – probabilmente non abbiamo. All’estero, ad ogni modo, la conoscenza sulla nostra gastronomia è limitata a pochi prodotti fra la nostra grandissima varietà, dato che conferma l’insufficienza della nostra promozione.
I contenuti di Denominazione di origine inventata che abbiamo presentato vi hanno spiazzato? Fateci sapere cosa ne pensate.