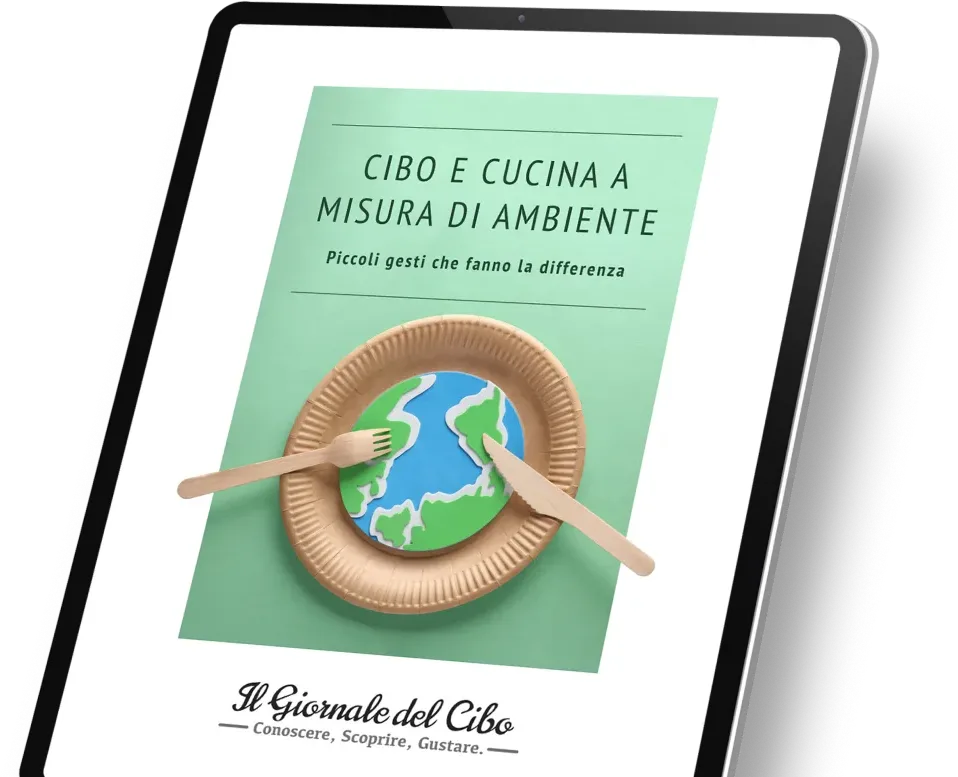In un’epoca dove ci sono più migranti che mai (uno ogni 35 persone), le appartenenze sono sempre più sradicate e i confini tra culture più labili. Per questo ci è parso importante guardare al fenomeno migratorio dal punto di vista alimentare, poiché il cibo, in quanto elemento primario per eccellenza, è da sempre strettamente connesso all’uomo e ai suoi movimenti.
Le culture, così come le abitudini, che siano esse alimentari o meno, cambiano nel tempo, si muovono e si evolvono, come e insieme alle persone. Infatti, non possiamo, ad esempio, ritenere che il chicken tikka masala sia il piatto più popolare del Regno Unito, dove risiede la più grande comunità indiana d’Europa? E che dire allora del kebab, il fast food più diffuso in Germania, dove a partire dal secondo dopoguerra sono emigrati migliaia di lavoratori turchi? Oggi, dunque, parleremo di tre casi di cibo e migrazioni che ci sono sembrati particolarmente emblematici, nella speranza che suscitino anche il vostro interesse.
Cibo e migrazioni: tre storie di incontri gustosi
Nel riflettere sul rapporto tra cibo e fenomeni migratori ci è parso interessante affrontare questi tre casi per dimostrare come storicamente le migrazioni non abbiano tolto nulla ai vari paesi, ma anzi, li abbiano arricchiti culturalmente in modo duraturo, se permanente ancora non ci è dato saperlo.
Inizieremo da lontano, ovvero dall’antica presenza degli arabi in Sicilia, ancora molto evidente oggi non solo in campo alimentare, ma anche linguistico, culturale, architettonico; in seguito passeremo ad un fenomeno più recente, ovvero quello dell’emigrazione calabrese in Valle d’Aosta, avvenuta nel corso degli anni Sessanta; infine, quella ancora in corso, quella che sta entrando, cambiando e rendendo ancora possibile alcune attività agricole, come quella degli indiani impegnati nell’ambito della pastorizia.
Gli arabi in Sicilia
Osservando e studiando le abitudini alimentari in Sicilia, spiccano una serie di stratificazioni che diventano importanti non solo per la storia dell’alimentazione, ma per la storia in generale. Infatti, qui la dominazione araba si sente ancora ovunque: ha lasciato tracce forti dai nomi delle strade, alla struttura delle case e dei quartieri, fino, appunto, al mondo del cibo.
A tal proposito si può partire dall’inizio, ovvero dal cibo più popolare per eccellenza: il pane, che si distingue proprio per la presenza dei semi di sesamo, ingrediente molto diffuso nella cucina araba. Lo stesso sesamo si ritrova anche nei dolci, come la cubbàita o i katayef, simili alle cassate; inoltre, persino la parola siciliana per indicarlo, cioè giuggulena, è di origine araba. Che dire dello street food per eccellenza, pane e panelle, preparato con la farina di ceci che, guarda caso, è tra gli ingredienti più utilizzati nella gastronomia orientale? O ancora vale la pena riflettere sul fatto che , in tutto il mondo arabo si usa cucinare un’insalata di peperoni e melanzane, simile alla caponata o alla peperonata, una pietanza molto diffusa in Sicilia. E così, in generale, spesso i sapori della cucina siciliana sono combinazioni ardite, “stratificate” appunto, come la pasta con le sarde, pinoli, uva passa, ma soprattutto con lo zafferano, altro ingrediente da ricongiungere alle matrici nordafricane.
Fino al simbolo per eccellenza di questo incontro, il cous cous, o il cùscusu come lo chiamano in Sicilia (sempre a dimostrazione degli scambi nel Mediterraneo pensate che in Sardegna lo chiamano soccu e in Liguria succu): seppur in numerose varianti, continua a caratterizzare la cucina domestica, in particolare nella tradizionale versione con il brodo di pesce nel Trapanese. E allora ecco che il cibo e l’alimentazione diventano la prova inconfutabile che stabilire confini tra luoghi, comunità e culture è impossibile, a maggior ragione in questi tempi islamofobi, dove dal confronto non potrebbero che uscirne arricchite tanto le tavole quanto le persone.
I calabresi in Valle d’Aosta
Quando sono arrivata ad Aosta e ho visto cipolle di Tropea nei mercati, ‘nduja nei negozi e peperoncini appesi sui balconi, ho pensato che era successo qualcosa di cui non ero a conoscenza. Così sono venuta a sapere della consistente emigrazione calabrese avvenuta negli anni Sessanta in Valle d’Aosta, principalmente per due ragioni: la prima fu la costruzione dei trafori del Monte Bianco e del San Bernardo, la seconda il lavoro alla Cogne Acciai Speciali, la famosa azienda siderurgica di Aosta, che ha segnato uno sviluppo urbano notevole con la costruzione di nuovi quartieri popolari, come appunto il quartiere Cogne. Così, la creazione di migliaia di posti di lavoro ha fatto sì che moltissimi calabresi restassero in Valle, occupati proprio nel settore edilizio.
Questo incontro ha determinato una serie di scambi prima di tutto sociali. Infatti, ad esempio, da anni nel mese di luglio si festeggia ad Aosta la Festa di San Giorgio e Giacomo, patroni di San Giorgio Morgeto, piccolo comune dell’Aspromonte. Nata come punto di riferimento della comunità calabrese, oggi vede la partecipazione attiva anche di moltissimi valdostani, gli stessi che poi passano spesso pure le vacanze giù in Calabria.
Da un punto di vista più strettamente alimentare, il primo segno della loro presenza è ben evidente nei cosiddetti “giardini”, oggi diffusi tutti in ordine, in particolare in alcuni quartieri, come la regione consolata di Aosta, dentro la città o ai bordi del fiume Dora.
I “giardini”, culto fondamentale e imprescindibile per i calabresi, sono delle aree verdi, dove coltivare il proprio orto e tenere qualche animale, come galline o conigli. In passato avevano tentato anche con i maiali (che vi avevamo già detto quanto è importante nell’alimentazione del calabrese, soprattutto del reggino); ma il clima o altre motivazioni sconosciute non l’hanno consentito. Così, ci racconta Maria, originaria di Catanzaro ormai trapiantata ad Aosta, “abbiamo continuato ad avere il maiale, ma giù in Calabria; lo ammazzavamo quando scendevamo giù per le feste, come vuole la tradizione, e poi salivamo in treno, durante quei lunghi viaggi, con i salaturi, cioè dei vasi rotondi, alti e cilindrici con dentro tutte le parti del maiale”.
Tornando ai giardini, grazie alla loro presenza, sono principalmente tre i prodotti che si sono diffusi a pieno titolo in Valle, con semi importati dalla Calabria: la cipolla di Tropea, i pomodori e i peperoncini, sia quelli verdi, cioè i friarelli, sia quelli rossi piccanti, che si mettono un po’ su ogni piatto, anche nella versione in polvere, “u pipi pistatu”, oggi spesso anche nei ristoranti. Ma ricordiamo di non fare di tutta la Calabria un fascio, poiché il peperoncino è molto diffuso nella parte alta della regione, cioè nella provincia di Cosenza, ma molto meno in quella di Reggio.
Grazie alla presenza di questi pomodori, anche i valdostani hanno iniziato a preparare le conserve “alla calabrese”, ovvero nelle bottiglie e, tra uno scambio e l’altro, si sono anche ritrovati vicini, come racconta sempre Maria. “Abbiamo scoperto che la stessa polenta di mais che si mangia qui in Valle con i formaggi, è anche il piatto tipico del paese di mio marito, Buonvicino, sulla collina di Diamante; solo che lì la accompagnano alle verdure”. Che ancora una volta ci sia da lezione, come proprio a partire dalla tavola, siamo tutti, in fondo, più vicini. Neanche a dirlo, ovviamente arance e mandarini che si trovano in Valle d’Aosta sono calabresi, così come anche il pane, frutto di un frequente e vivace scambio di lievito madre tra donne. Conclude Maria: “in fondo ci siamo trovati, poiché i valdostani sono contadini come noi”. E io aggiungo, un po’ come tutti gli italiani fino a cinquant’anni fa, o sbaglio?
Gli indiani nella pastorizia
Mi preme accennare ad un altro tema immenso che non riguarda le abitudini alimentari in tavola, ma la produzione di cibo, sempre in connessione al fenomeno migratorio. Ed è quello che riguarda le attività agricole, in particolare la pastorizia, poiché oggi è in corso un cambiamento di fondamentale importanza: gran parte dei pastori che transumano con gli animali sono indiani, in particolare quelli di bovini, probabilmente per il valore sacro che ha la mucca in India. Ad esempio, ci spiega una famiglia indiana di Punjab che vive e lavora alle Fattorie Fiandino di Villafalletto, in Piemonte: “anche in India avevamo le vacche e facevamo formaggi freschi”.
Così come non è forse anche vero che a vendemmiare, raccogliere patate, frutti di bosco e pomodori, o svolgere altre attività agricole, sono sempre di più “gli immigrati”, quegli stessi che ci rubano il lavoro nei discorsi al bar?
In realtà non solo gli immigrati svolgono lavori che i locali si rifiutano di fare, ma portano avanti attività produttive che richiedono competenze specifiche che spesso gli autoctoni non hanno. È questo, ad esempio, il caso di Vincenzo Evola e delle sue vacche di Cinisi: “se non fosse stato per questa famiglia di indiani che da 20 anni mi tiene le vacche al pascolo tutti i giorni, avrei dovuto chiudere, poiché i miei compaesani nemmeno per 100 euro farebbero questo. E poi comunque non lo farebbero bene come loro, non lo sanno fare”. Fin qui tutto bene, o meglio, quasi. Perché “essere utili” non dovrebbe essere il prezzo da pagare per l’accettazione, altrimenti non si tratta che di una tolleranza vestita di buone intenzioni.
Infine non è forse un po’ lo stesso discorso che vale per la cucina cinese o per sushi e sashimi ormai in ogni via, soprattutto a Milano? Ebbene sì, poiché per fortuna i piatti tradizionali di un luogo non sono dati e definiti una volta per tutte, ma cambiano, si evolvono e si aprono anche a nuove realtà. E allora, a dimostrazione di quanto detto, non ci resta che andare a preparare un bel sushi fatto in casa!