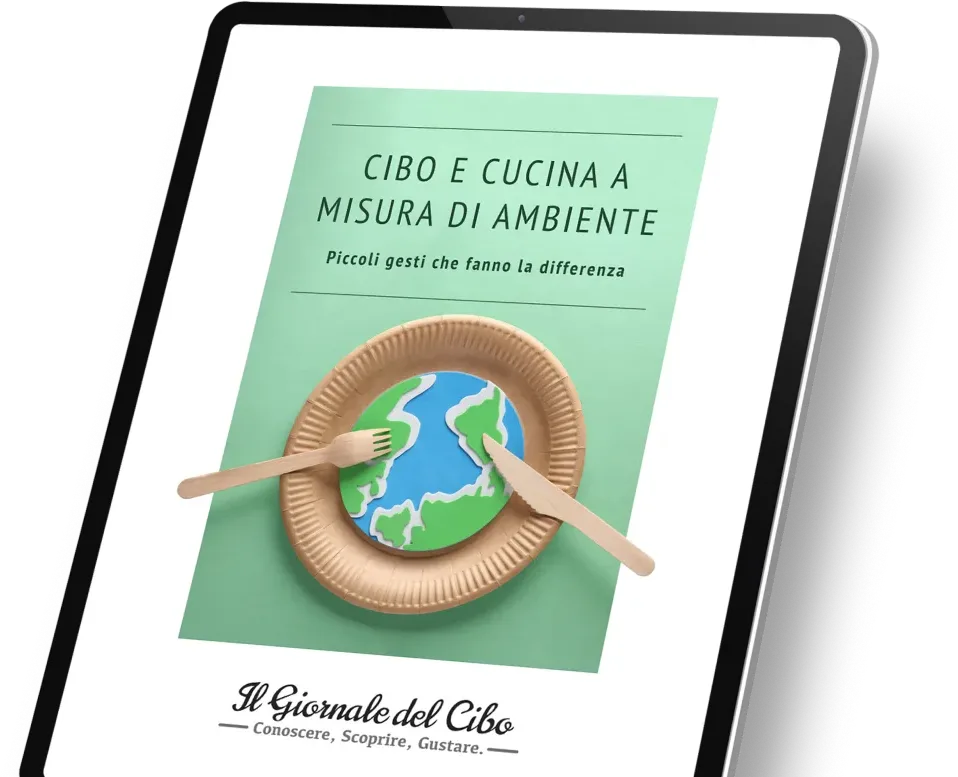Dagli anni Cinquanta ad oggi la produzione di soia nel mondo è cresciuta di ben 21 volte, passando da 16 milioni di tonnellate all’anno a 352 milioni, nel 2017. Un aumento drastico e costante che ha portato a una diffusione per milioni di ettari di questa coltivazione, in spazi molto spesso dedicati alla monocoltura. Esiste addirittura un’area dell’America Latina chiamata “La repubblica della soia”, tra Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia e Brasile, che è il principale produttore. Proprio qui è girato parte di “Soyalism”, il documentario di Enrico Parenti e del giornalista Stefano Liberti che indaga il funzionamento della filiera della soia e il legame imprescindibile con il sistema dell’allevamento intensivo dei suini. Qual è il nesso e perché c’è bisogno di così tanta soia? L’abbiamo chiesto direttamente a Stefano Liberti, autore anche del volume “I signori del cibo”.
Produzione soia: Stefano Liberti racconta come funziona la filiera
La crescita esponenziale della produzione di soia non è determinata dall’aumento della domanda di prodotti a base di questo cereale per l’alimentazione umana. Infatti, sebbene sia presentata spesso come un valido sostituto delle proteine animali, per chi segue una dieta vegetariana o vegana, la soia è destinata per il 70% ai mangimi necessari per nutrire suini allevati in tutto il mondo.
“È vero che il mondo richiede soia – spiega Liberti – e lo fa per produrre carne. Sono più di 30 anni che viene utilizzata negli allevamenti intensivi, perché ha un ottimo valore energetico per gli animali.” Nello stesso periodo, infatti, è cresciuto notevolmente anche il consumo di carne a livello globale, soprattutto in Cina, dove vengono allevati e macellati ogni anno 700 milioni di maiali, mentre in Italia 9 milioni. Il Paese non ha una superficie coltivabile sufficiente per produrre la quantità necessaria agli allevamenti e la importa principalmente dal Brasile.
Il funzionamento della filiera della soia destinata a questo scopo è simile in tutto il mondo. Troviamo, infatti, enormi distese dedicate a monocoltura: la produzione è in mano a grandi aziende locali che possono raggiungere anche i 200 mila ettari di superficie e che, di fatto, non hanno bisogno di manodopera. “In Brasile, abbiamo visto una persona ogni tanto che serviva alla semina – spiega Liberti – i diserbanti vengono poi distribuiti tramite gli aerei e, infine, c’è bisogno di qualcuno che guidi le mietitrebbiatrici per la raccolta. Di fatto, la campagna si trasforma in una grande industria, distese vuote, disabitate dove vengono prodotti milioni di kg di soia portati nei porti a 200 km e poi caricati su navi cargo che vanno in tutto il mondo, fino a Ravenna dove sbarcano per nutrire gli allevamenti della Pianura Padana.”

Mato Grosso, la “foresta spessa” che non c’è più
Il prezzo da pagare per questo sistema è ambientale e sociale, e si percepisce in maniera evidente guardando al Mato Grosso, una zona del Brasile chiamata così perché in portoghese significa ‘foresta spessa’. “Oggi la vegetazione non c’è più, c’è solo soia – commenta Liberti – e i confini delle piantagioni si stanno spingendo sempre più avanti anche nella Foresta Amazzonica.”
Dal punto di vista ambientale, è riconosciuto come le monocolture, soprattutto quelle che impiegano moltissimi agenti agrochimici, comportano una notevole perdita di biodiversità. Insieme agli alberi della foresta, sono spariti anche tutti gli organismi che li popolavano, comprese le persone. “Con questo tipo di monocolture – aggiunge l’intervistato – si va a ridurre la complessità e la capacità di resilienza di un sistema, rendendo un’area anche più vulnerabile alle conseguenze del cambiamento climatico.”
L’inaridimento non è soltanto fisico, ma anche umano. Spariscono, infatti, i piccoli contadini e i terreni diventano luoghi di produzione gestiti da grandi latifondisti che non coltivano, insieme alle piante, il tessuto sociale. “Lo spostamento umano dalle campagne verso le città è un fenomeno mondiale – riflette Liberti – ma in aree così vaste come il Sud America o gli Stati Uniti gioca un ruolo preponderante.”

Dal Brasile al Mozambico: l’esportazione funziona del modello?
“Abbiamo scelto di raccontare il Brasile – spiega Liberti – perché è il caso più emblematico, ma il modello è uguale in Argentina o Uruguay.” Nella ‘Repubblica della soia’, dunque, la filiera funziona così e sono stati diversi i tentativi di esportare questo stesso modello produttivo, il più importante in Mozambico con il progetto Pro Savana finanziato da fondi brasiliani e giapponesi.
Tuttavia, come ci racconta il giornalista, non ha funzionato. La zona dove si voleva introdurre questo sistema di produzione intensiva della soia era densamente abitata da persone abituate a coltivare la terra. “Quando hanno scoperto del progetto Pro Savana, hanno messo in piedi una campagna, diffusasi grazie alla rete in tutto il mondo, e sono riusciti a bloccare il programma.”
Liberti sottolinea che nel tessuto sociale africano le persone vivono a stretto contatto con la terra, che è pubblica, ma data in gestione alle comunità. “Appropriarsi dei terreni non è mai pacifico poiché è necessario convincere interi gruppi a cedere l’usufrutto delle terre per raggiungere una superficie pari a quelle brasiliane.”
Inoltre, esiste il problema della carenza di infrastrutture che renderebbe più complicato il passaggio della soia dal Mozambico al resto del mondo, dove si trovano gli allevamenti. “L’Africa resta nel mirino, ma non penso sia possibile raggiungere i livelli del del Mato Grosso. Lì, infatti, lo sviluppo della filiera è partito negli anni Ottanta, quando il Brasile era governato da un regime dittatoriale e non c’erano gli stessi mezzi di comunicazione che hanno permesso, oggi, alle istanze dei contadini mozambicani di essere ascoltate ovunque.”

Verso una coltivazione sostenibile della soia
La preoccupazione è che, nonostante gli episodi di resistenza del Mozambico, la continua domanda di carne nei supermercati di tutto il mondo richieda sempre più soia. Secondo le stime di Tony Weis, professore di geografia all’università di Western Ontario e autore del libro “The Ecological Hoofprint. The Global Burden of Industrial Livestock”, dal 2050 sono 120 miliardi gli animali d’allevamento necessari, ogni anno, per rispondere alle esigenze del mercato, animali che prima dovranno essere nutriti, naturalmente, grazie alla soia.
“Dal punto di vista del consumatore – aggiunge il giornalista – dico spesso che non riflettiamo abbastanza quando consumiamo la carne: se il prezzo è molto basso, il prodotto con ogni probabilità viene da allevamenti intensivi, perché non tiene conto delle esternalità negative, ovvero tutti quei costi ambientali e sociali della filiera.” In altre parole, non considera il consumo di suolo, l’inquinamento, i rifiuti, la deforestazione, le emissioni di CO2, l’impronta idrica.
“Ci piacerebbe poter aprire un dibattito – aggiunge l’intervistato – perché anche l’Italia produce molta carne. Anche eccellenze, come i prosciutti di Parma o San Daniele, preferiscono la scala industriale, che porta a prezzi accessibili e grandi quantità di prodotto. In Spagna, per esempio, per alcuni prodotti come il Pata Negra, è stata decisa una via differente con allevamenti all’aperto, meno capi,un prezzo che porta a un consumo migliore e minore.” L’auspicio del giornalista è che si possa trovare un equilibrio tra la volontà di mangiare proteine animali e un metodo di produzione più in sintonia dell’ambiente che non produca quei danni.

E la soia che mangiamo?
Il paradosso, quando parliamo della soia, è che è cardine dell’allevamento intensivo, ma anche molto preziosa per l’alimentazione umana. “Le filiere però sono completamente diverse: il tofu o i germogli che mangiamo qui non vengono dal Sud America. I prodotti a base di soia nei supermercati, infatti, provengono principalmente dall’Europa, e vengono realizzati in maniera diversa seguendo le normative promosse dall’UE e garantite dall’EFSA.”
La questione è, dunque, tutta legata alle enormi quantità di soia necessarie per nutrire gli animali che permettono di trovare la carne sui banchi del supermercato. Conoscevate le conseguenze ambientali e sociali di questa filiera?