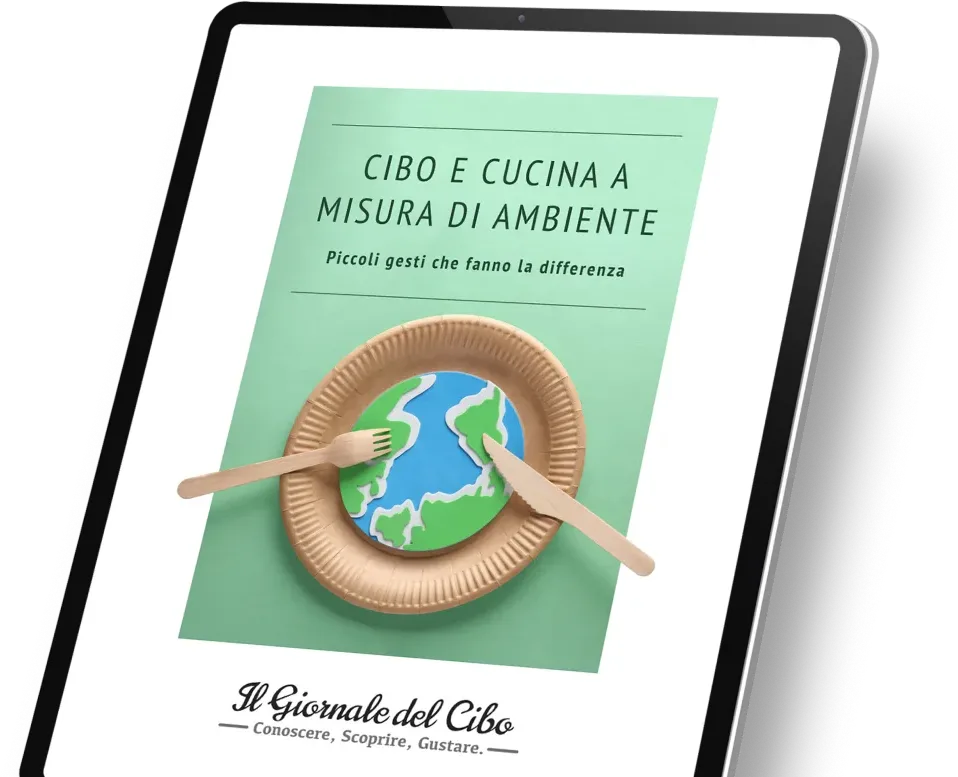Un paio di anni fa Annamaria Testa (una delle maggiori esperte di comunicazione italiane, una copy che ha creato tante pubblicità di successo, come la campagna Perlana e Ferrarelle) ha deciso di lottare contro l’uso smodato, immaturo, provinciale e subalterno dell’inglese. La sua petizione “dillo in italiano”, rivolta alla Accademia della Crusca affinché si mobiliti con il Governo per la difesa della lingua italiana, lanciata su Change.Org (ironia della sorte: una petizione contro l’uso smodato dell’inglese lanciata su una piattaforma “in inglese”) è stata firmata in poco tempo da decine di migliaia di persone.
L’ossessione per i termini inglesi
Sono d’accordo con questa petizione, l’ho firmata, ma purtroppo temo che io, Annamaria Testa e tanti altri siamo, in questo momento storico, perdenti. Siamo perdenti disincantati, naturalmente, e comunque felici di parlare italiano, anche se è un piacere che condividiamo ormai con pochi: mi tocca, infatti, tapparmi le orecchie sempre più spesso, e questo ammetto è fastidioso. Perché mi devo tappare le orecchie sempre più spesso? Perché continuo a ricevere messaggi che sono ormai una lingua mista, pieni di termini inglesi del tipo: “Come scegliere il giusto influencer? Quali sono i top brand nel food? E scoprite la nuova sorprendente location per i vostri eventi a Milano!” o, come ricorda Anna Maria Testa, “facciamo asap un meeting per il fine tuning del client service.” Che bisogno c’è? Forse un termine inglese fa figo? Ma a chi? Ai residuati con pancetta e capelli bianchi delle tre “i”?
Lingua e cibo come identità
Perché, in particolare nel mondo economico, della comunicazione aziendale, c’è così tanto autolesionismo? Penso che il senso di identità di un individuo, come di un popolo, si formi e si mantenga attorno ad alcuni valori come la storia del proprio paese, la bellezza del territorio e delle creazioni artistiche, il cibo. E probabilmente, prima di tutto, la lingua. Se io italiano non sfrutto la lingua italiana per vendere, per esempio, i prodotti italiani all’estero, sono proprio stupido. Perché scrivo italian wine invece di vino italiano? Se si pensa che la scritta “vino italiano” su una etichetta incollata a una bottiglia di vino non si capisca all’estero (cosa di cui dubito) scriviamo “vino italiano” e sotto, più in piccolo italian wine, e magari onoreremo così un buon bilinguismo.
Dillo in italiano: in difesa della lingua italiana
Il paradosso che alimentano questi nostri ambasciatori d’Italia alla rovescia con il loro uso dell’inglese (pensiamo a “eic-har” invece del bellissimo risorse umane) è che mentre l’italiano è una delle lingue più studiate al mondo loro, in Italia, parlano inglese! Inglese: magari. Parlano più spesso un inglesorum che mischiato a un cattivo italiano fa del loro discorso un orrore. Un orrore perdente.
In una bellissima vignetta un personaggio di Altan dice all’altro: “Il tuo italiano è pessimo”. E l’altro risponde: “Non hai ancora sentito come fa cagare il mio inglese.”
Le parole hanno una grande forza. Sulle parole corre anche il successo o l’insuccesso di un Paese. Ormai la parola “computer” è entrata nell’uso comune, e nessuno, nemmeno un anti-inglese come me, propone ovviamente di cambiarla. Ci sono parole (Anna Maria Testa ricorda tram, kitsch, strudel, festival e così via) che non hanno corrispondenti altrettanto semplici, efficaci e diffusi. Ma è una questione di misura. Nel caso citato più sopra: invece di “facciamo asap un meeting per il fine tuning del client service.” non si può dire: “facciamo al più presto una riunione per mettere a punto il servizio clienti”? Dillo in italiano!
Un tempo in Italia si diceva “Calcolatore” che a me sembra più bello di computer. In Francia dicono ordinateur, in Portogallo cuntadora. Calcolatore non è più bello e corto più o meno uguale, di computer? E il sospetto è: se avessimo continuato a dire “calcolatore” invece di passare a “computer” l’Olivetti e l’Italia non potrebbero essere ancora i primi al mondo nella produzione di “calcolatori”?